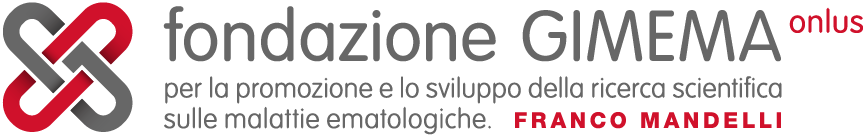Le conseguenze dell’anemia falciforme, spesso sottovalutate, rimangono ancora oggi gravi, soprattutto per i pazienti e le famiglie. Potrebbero essere però evitate con una prevenzione tempestiva ed estesa sulla popolazione.
Includere lo screening dell’anemia falciforme nel programma di prevenzione nazionale è necessario quanto possibile. Lo dimostrano i risultati dello studio pilota pubblicato sull’European Journal of Pediatrics dal gruppo di ricerca di Silverio Perrotta dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, a Napoli.
L’anemia falciforme è la condizione più comune tra le emoglobinopatie, patologie caratterizzate da una conformazione anomala dei globuli rossi, che comporta una serie di gravi sintomi potenzialmente letali. Con circa 300.000 nuove diagnosi all’anno, le emoglobinopatie rimangono, nel complesso, delle malattie rare che, per la loro origine genetica, trovano una maggiore incidenza in particolari aree geografiche, come in alcune parti dell’Africa e dei Paesi Mediterranei.
Il numero dei pazienti è aumentato negli ultimi anni anche in zone dove in passato erano presenti meno pazienti, come nel Nord Italia, a causa di fenomeni migratori. Eppure i rischi dell’anemia falciforme sembrano essere perlopiù sottovalutati.
“Questa patologia non viene ancora considerata come una priorità di diagnosi e cura”, commenta Maddalena Casale, prima autrice dello studio.
“Malattie decisamente più rare dell’anemia falciforme, come la fibrosi cistica, hanno ricevuto una maggiore attenzione da parte sia della comunità scientifica, sia delle istituzioni sanitarie”. Una delle conseguenze più evidenti di questo fenomeno è l’estrema difficoltà di molti pazienti a ricevere la diagnosi, soprattutto in tempo per prevenire la comparsa di sintomi.
Le complicanze dell’anemia falciforme comprendono infezioni, lesioni a livello cerebrale, polmonare, osseo, e intense crisi di dolore. “Senza una diagnosi, i pazienti sono costretti a richiedere continuamente assistenza medica”, spiega Casale. “I danni non riguardano soltanto loro stessi e le loro famiglie, ma anche i sistemi sanitari nazionali e regionali per i costi elevati del supporto clinico”.
Organizzare in modo strutturato diagnosi tempestive potrebbe aiutare ad effettuare una diagnosi precoce, iniziare la cura con idrossicarbamide dai 9 mesi di età, ed evitare la maggior parte delle complicanze. Dal momento che la prevenzione dell’anemia falciforme non è ancora organizzata in maniera sistematica in Italia, a differenza di molti altri Paesi, il gruppo di ricerca ha dunque condotto uno studio pilota per dimostrare quanto sia realizzabile e necessaria.
Meno di un pediatra su 4 contattato ha acconsentito a partecipare all’iniziativa e 1.000 bambini sono stati sottoposti all’esame di screening, di cui 85 sono risultati positivi. Come previsto, la maggiore parte di loro ha origini africane, ma una percentuale che spazia tra il 2 e il 13% proviene da Europa, America e Asia. Per ottimizzare il processo sono stati utilizzati i test point-of-care, molto usati durante la pandemia da Covid-19, che permettono di rilevare le anomalie dell’emoglobina (Hb) ed effettuare la diagnosi in modo semplice, pratico ed economico. Per utilizzarli basta una goccia di sangue, per questo possono essere offerti dai pediatri di base ai bambini seguiti regolarmente nei loro ambulatori.
“Lo studio mostra che l’anemia falciforme rientra in tutte le caratteristiche necessarie perché il suo esame di screening sia inserito nel programma di prevenzione del sistema sanitario nazionale”, dice Casale. “Tra queste, la gravità delle conseguenze cliniche, la semplicità del test e l’efficacia del trattamento precoce con idrossicarbamide”.
Il generale disinteresse per la patologia potrebbe però ostacolare il lungo percorso legislativo necessario per l’approvazione della misura. Ne è un esempio anche il basso numero di medici che hanno partecipato allo studio, che secondo la ricercatrice è legato alla mancanza di una solida didattica fin dalla formazione universitaria. Inoltre, manca una reale consapevolezza anche da parte dei pazienti, che spesso si trovano ad affrontare le barriere linguistiche e culturali del Paese ospitante. “Nel 2023, è stata approvata la legge per l’esame di prevenzione per la celiachia e il diabete in età pediatrica, grazie alle pressioni combinate della comunità scientifica, associazioni di pazienti, opinione pubblica e mediatica”, conclude Casale. “Questo caso mostra che è necessario agire a più livelli per raggiungere l’obiettivo e richiedere un intervento legislativo.”
Lo studio completo si può leggere al seguente link: https://doi.org/10.1007/s00431-025-05988-y