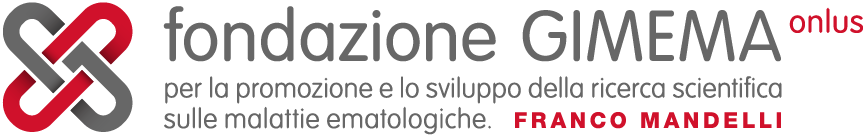La leucemia promielocitica acuta correlata a precedenti terapie (t-APL) è una sfida per l’onco-ematologia: rara, complessa e legata a pregressi trattamenti oncologici, richiede un approccio terapeutico personalizzato. Uno studio analizza tre casi clinici, sottolineando l’importanza della condivisione dei dati per affinare le strategie terapeutiche e migliorare la gestione di questa malattia.
C’è un aspetto che accomuna molte patologie rare: la difficoltà nello stabilire protocolli di trattamento validi ed efficaci. Pochi casi, infatti, significa anche pochi dati. Ma la salute è un diritto di tutti, anche delle persone con patologie molto rare.
Per questa ragione, un recente articolo pubblicato sull’European Journal of Haematology riporta tre casi di pazienti con leucemia promielocitica acuta correlata a precedenti terapie (t-APL), trattati presso l’Ospedale di Cosenza tra il 2022 e il 2024. È un passo in più nella condivisione di informazioni su una patologia che si osserva raramente e per la quale condividere le informazioni è fondamentale.
Tre casi di t-APL, tre trattamenti diversi
La leucemia promielocitica acuta correlata a pregresse terapie è una rara forma di leucemia mieloide acuta secondaria che insorge dopo trattamenti chemioterapici, in particolare con agenti alchilanti e inibitori della topoisomerasi II. “La leucemia promielocitica, se prontamente riconosciuta e trattata, ha solitamente una buona prognosi, ma sappiamo poco delle forme secondarie”, spiega Antonella Bruzzese, ematologa dell’Ospedale di Cosenza e prima autrice dell’articolo.
Questa condizione spesso si sviluppa dopo diversi anni dal trattamento oncologico, ma in alcuni casi insorge più precocemente. I tre pazienti descritti nel suddetto articolo sono uomini, tutti sopra i settant’anni. Il primo ha pregressi tumori del colon retto e della mammella (che, lo ricordiamo, seppur raramente può interessare anche gli uomini); il secondo ha una storia di carcinoma del colon-retto, mentre il terzo una storia di carcinoma squamocellulare polmonare. I tre pazienti hanno ricevuto trattamenti antineoplastici tra loro differenti, ma tutti hanno sviluppato una t-APL.
La terapia per la t-APL nei i tre pazienti è stata come segue: il primo, classificato a basso rischio, ha ricevuto solo acido all-trans retinoico (ATRA), un farmaco che ha un ruolo cardine nel trattamento della leucemia promielocitica. Questa malattia è infatti caratterizzata dalla traslocazione di un gene che blocca la differenziazione dei promielociti (i precursori immaturi dei granulociti) nel midollo osseo. L’ATRA favorisce la trascrizione dei geni coinvolti nella differenziazione cellulare; così, le cellule leucemiche completano la maturazione e muoiono naturalmente, invece di proliferare in modo incontrollato. Il secondo paziente, classificato ad alto rischio sulla base dell’emocromo d’esordio (valore dei globuli bianchi più elevato), ha ricevuto una combinazione di ATRA e idarubicina, un farmaco chemioterapico appartenente alla classe delle antracicline. Il terzo paziente, classificato a rischio intermedio, ha ricevuto una terapia “chemio-free” a base di una combinazione di ATRA e triossido di arsenico (ATO), altro farmaco in grado di impedire la produzione di DNA necessaria per la crescita delle cellule leucemiche.
Due dei pazienti trattati, quello trattato con solo ATRA e quello trattato con ATRA e idarubicina, hanno ottenuto la remissione completa della malattia. Il terzo, invece, è deceduto a pochi giorni dall’inizio del trattamento per l’insorgenza di “pseudotumor cerebri”, complicanza che può verificarsi in corso di terapia con i farmaci differenzianti.
Capire il futuro del trattamento della t-APL
Questi casi sono troppo pochi, dal punto di vista numerico, per offrire indicazioni concrete sul miglior approccio terapeutico da applicare per la t-APL. “Ma la condivisione dell’esperienza e delle conoscenze è il punto di partenza fondamentale per arrivare a protocolli condivisi”, commenta Bruzzese.
“La t-APL non è solo rara. Come forma tumorale secondaria, è anche caratterizzata dalla difficoltà di capire se eventuali complicanze legate al trattamento possano in qualche modo essere influenzate dalle terapie precedenti. Inoltre sarebbe necessario studiare questa malattia anche dal punto di vista biologico per comprendere meglio come i precedenti trattamenti possano influire sulla biologia della cellula leucemica e sulla sua risposta alla terapia”.
Ogni paziente porta con sé una storia clinica unica, spesso segnata da terapie oncologiche pregresse che possono influenzare sia l’insorgenza della malattia che la risposta ai trattamenti. I casi analizzati mostrano come il confine tra successo terapeutico e complicanze sia ancora labile, specie nei pazienti più anziani o con trattamenti oncologici complessi alle spalle. L’obiettivo per il futuro, allora, non è solo affinare le strategie terapeutiche, ma anche sviluppare strumenti predittivi più precisi per individuare il trattamento ottimale per ogni paziente, minimizzando il rischio di tossicità e migliorando la sopravvivenza a lungo termine.
La pubblicazione sull’European Journal of Haematology è disponibile qui: https://doi.org/10.1111/ejh.14327