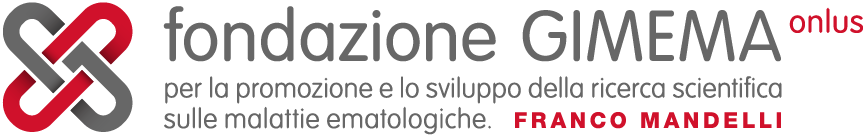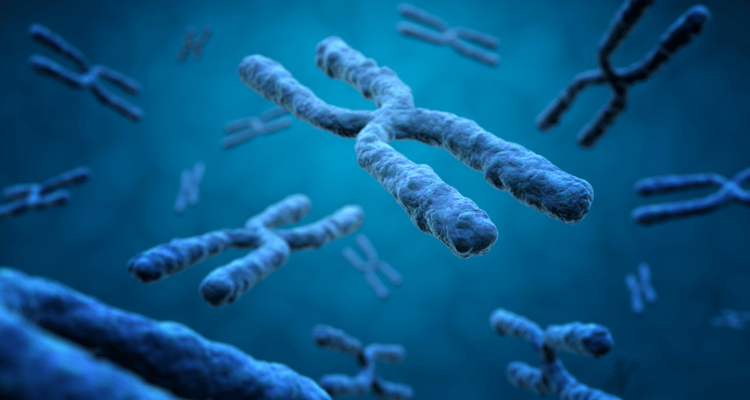Negli ultimi anni, la ricerca ha fatto importanti passi avanti nel comprendere i fattori molecolari che influenzano il decorso della leucemia linfatica cronica. Tra queste, il cosiddetto cariotipo complesso (CK) si è rivelato un importante marcatore di rischio. Una revisione della letteratura, pubblicata sul British Journal of Haematology, riassume tutte le strategie terapeutiche efficaci in pazienti che presentano questo cariotipo, nei quali la terapia standard aveva dato scarsi risultati.
La leucemia linfatica cronica (CLL, nell’acronimo inglese) è una neoplasia del sangue che colpisce i linfociti B – cellule cruciali del nostro sistema immunitario – ed è caratterizzata da un andamento clinico estremamente variabile: alcuni pazienti possono convivere con la malattia per anni senza necessità di trattamento, altri invece presentano una forma più aggressiva sin dalla diagnosi.
Questa eterogeneità è in gran parte dovuta alla complessità genetica della CLL. Negli ultimi anni, la ricerca ha fatto importanti passi avanti nel comprendere i fattori molecolari che influenzano il decorso della malattia, grazie all’analisi del profilo citogenetico e genomico delle cellule leucemiche, evidenziandone le peculiarità. Tra queste, il cosiddetto cariotipo complesso (CK) – definito dalla presenza di almeno tre alterazioni cromosomiche nella cellula tumorale – si è rivelato un importante marcatore di rischio. Si stima che circa il 15-20% dei pazienti presenti una sola alterazione alla diagnosi, ma la percentuale sale fino al 40% nei casi più avanzati o recidivati.
Il cariotipo complesso non è un semplice “dettaglio” genetico. La sua presenza si associa infatti a un decorso più aggressivo della malattia, a una minore risposta alle terapie convenzionali e a una sopravvivenza ridotta.
Inoltre, i pazienti con cariotipo complesso sono anche a maggior rischio di sviluppare la sindrome di Richter, una complicanza rara ma grave della CLL in cui la leucemia si trasforma in un linfoma molto aggressivo.
Un gruppo di ricercatori italiani dell’Università di Padova ha analizzato le terapie che hanno prodotto i maggiori risultati nel trattamento di questa forma di leucemia. La revisione è stata pubblicata sulla rivista scientifica British Journal of Haematology.
Andrea Visentin, tra gli autori dello studio, ha tenuto a sottolineare a GIMEMA informazione l’importanza del corretto inquadramento di questi pazienti:
“L’analisi del cariotipo, benché sia molto utilizzata in ematologica, è entrata nella stratificazione prognostica dei pazienti con CLL solo di recente, poiché i pazienti con tale caratteristica sono maggiormente proni a diventare resistenti ai trattamenti. Nella gestione di questi pazienti bisogna programmare fin da subito quello che sarà il percorso del paziente. Non solo la prima linea di terapia, ma anche pensare già alla quarta o quinta terapia. Fondamentale è quindi utilizzare strategie terapeutiche di durata limitata che permettano di controllare la malattia senza acquisire resistenza, e quindi di ripeterla se necessario”.
Fino a pochi anni fa, lo schema più utilizzato per trattare questa leucemia era la combinazione di chemioterapia e immunoterapia, ad esempio la combinazione bendamustina e rituximab (BR).
Tuttavia, nei pazienti con leucemia linfatica cronica con cariotipo complesso questa strategia si è rivelata poco efficace, portando i ricercatori allo studio di strategie più mirate.
In particolare, l’arrivo degli inibitori della tirosinchinasi di Bruton (BTK), come ibrutinib, acalabrutinib e zanubrutinib, ha rappresentato una vera svolta. Questi farmaci bloccano un segnale chiave per la sopravvivenza delle cellule leucemiche, consentendo di ottenere buoni risultati anche in pazienti con cariotipo complesso.
Lo studio Alliance 041202, su pazienti con età superiore ai 65 anni, non precedentemente trattati, ha dimostrato che ibrutinib mostra una buona efficacia anche nei soggetti con cariotipo complesso. Inoltre, un’analisi effettuata insieme ad altri trials ha confermato che la sopravvivenza libera da progressione di malattia (PFS) è simile nei pazienti con e senza cariotipo complesso.
Anche i BTK-inibitori più recenti sembrano efficaci. Nei trial ELEVATE-TN e SEQUOIA, acalabrutinib e zanubrutinib hanno mostrato risultati incoraggianti nei pazienti con leucemia linfatica cronica con cariotipo complesso, con una buona durata della risposta. In particolare, zanubrutinib ha migliorato la PFS rispetto alla chemio-immunoterapia anche nei sottogruppi considerati ad alto rischio.
Un’altra molecola promettente nel trattamento dei pazienti con cariotipo complesso, e in particolare se combinata con altri farmaci come gli anti-CD20 o gli inibitori BTK, è il venetoclax, un farmaco che induce la morte delle cellule tumorali bloccando la proteina BCL-2, responsabile della loro sopravvivenza. Tuttavia, nei casi con cariotipo complesso e molto complesso (high-cariotipo complesso) la malattia può ripresentarsi più precocemente. Questo suggerisce che la complessità genetica è comunque in grado di influenzare la durata della risposta. Nonostante questo, venetoclax rappresenta oggi una delle opzioni più efficaci e ben tollerate, ed è particolarmente utile in pazienti con mutazioni ad alto rischio, come quelle di TP53, un gene cruciale nel controllo della proliferazione delle cellule tumorali.
Anche nei pazienti con malattia recidivante o refrattaria, le terapie mirate hanno mostrato risultati superiori rispetto alla chemio-immunoterapia. Lo studio RESONATE, ad esempio, ha dimostrato che ibrutinib è efficace anche nei pazienti con cariotipo complesso in fase avanzata, mentre lo studio MURANO ha confermato la superiorità della combinazione venetoclax–rituximab rispetto alla combinazione di chemioterapia e immunoterapia.
Un ulteriore sguardo al futuro per i pazienti con cariotipo complesso ad altissimo rischio, spesso con resistenze multiple, viene dato inoltre dalle estremamente promettenti immunoterapie di ultima generazione, tra le quali gli anticorpi bispecifici, gli inibitori BTK di seconda generazione e le cellule CAR-T, cellule del sistema immunitario appositamente ingegnerizzate per riconoscere e attaccare le cellule tumorali.
L’obiettivo della medicina del futuro sarà costruire percorsi sempre più personalizzati, scegliendo la cura più adatta in base al profilo genetico del paziente.
La revisione originale è disponibile a questo link: https://doi.org/10.1111/bjh.19986