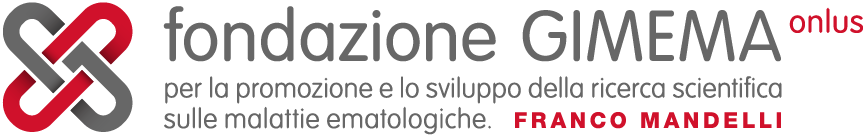Nei pazienti anziani affetti da leucemia acuta mieloide (AML) il tempo che intercorre fra la diagnosi e l’inizio del trattamento sembra non avere alcuna influenza sulla sopravvivenza globale quando la terapia include un farmaco ipometilante. Lo suggerisce uno studio retrospettivo pubblicato su Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Diseases.
La AML è un tumore delle cellule del sangue causato da una proliferazione rapida e incontrollata delle cellule staminali che risiedono nel midollo osseo e che sono normalmente responsabili della produzione di globuli rossi, globuli bianchi e piastrine. Più frequente negli uomini che nelle donne, la AML può insorgere a ogni età, anche se tende a prevalere in individui di età superiore a 65 anni.
In una patologia come questa, con decorso rapidamente progressivo, l’inizio immediato della terapia dopo la diagnosi ha storicamente rappresentato uno “standard di cura”.
Sebbene la AML rimane una potenziale emergenza ematologica (in particolare se sono presenti alla diagnosi coagulopatia, leucostasi o infezioni gravi), come spiegato da Matteo Molica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro, i risultati di uno studio di “real-world” del German Study Alliance Leukemia–Acute Myeloid Leukemia (SAL-AML) suggeriscono che un certo ritardo nell’inizio del trattamento, per i pazienti con condizioni generali adeguate e senza segni di disfunzione d’organo, non ha conseguenze negative in termini di risposta al trattamento, mortalità precoce o sopravvivenza.
Questa è una buona notizia, perché significa che i medici hanno tempo di personalizzare la terapia sulla base del profilo biologico della patologia, come raccomandato dalle linee guida del European LeukemiaNet.
“In questi pazienti c’è la necessità di effettuare tutta una serie di test biologici, molecolari e genetici che consentono di stratificare il paziente sul piano prognostico e personalizzare il trattamento in base alle caratteristiche biologiche della patologia. Per disporre dei risultati di questi test, e soprattutto dell’analisi di sequenziamento dei genomi (NGS), è necessaria una tempistica di esecuzione non altrimenti contraibile, e i risultati dello studio tedesco indicano quanto il tempo di attesa non sia dannoso per i pazienti giovani candidabili a chemioterapia intensiva”, spiega il dottor Molica.
Tuttavia, nei pazienti anziani affetti da AML, i dati relativi all’impatto sull’andamento di malattia dell’intervallo fra diagnosi e inizio di terapia sono ancora limitati nella letteratura corrente. Un lavoro di Molica e colleghi, pubblicato come “scientific letter” sulla rivista Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Diseases, affronta questo aspetto.
Nei pazienti anziani con AML, il carico di comorbidità è di forte impedimento ad un approccio terapeutico intensivo basato su chemioterapia e trapianto di cellule staminali allogenico. In questi pazienti l’impiego di un inibitore di BCL2 (venetoclax) in combinazione con un ipometilante (decitabina o azacitidina) oppure un inibitore della via di Hedgehog (glasdegib) associato a basse dosi di citarabina rappresentano oggi lo standard terapeutico.
Lo studio di Molica e colleghi ha incluso 220 pazienti di età maggiore di 75 anni che tra il 2010 e il 2023 hanno ricevuto un trattamento che comprendeva solo farmaci ipometilanti (164 con azacitidina; 56 con decitabina). Nell’analisi, finalizzata a valutare l’impatto del tempo fra la diagnosi e l’inizio della terapia (time from diagnosis to treatment start, TDT), i pazienti sono stati suddivisi in 4 coorti: TDT minore di 15 giorni (n= 85), fra 15-30 giorni (n = 64), fra 31-45 giorni (n= 33), maggiore di 45 (n= 38). La sopravvivenza globale mediana è stata di 7,5 mesi, 11 mesi, 7,4 mesi, e 7,6 mesi nelle coorti con TDT < 15, 15-30, 31-45 e > 45 giorni rispettivamente. La sopravvivenza libera da malattia mediana è stata di 5,8 mesi, 9,8 mesi, 5 mesi e 5,7 mesi per TDT < 15, 15-30, 31-45 e > 45 giorni rispettivamente. La sopravvivenza globale e la sopravvivenza libera da malattia non hanno mostrato differenze significative nei quattro gruppi; anche in questo caso il tempo fra la diagnosi e l’inizio della terapia non ha mostrato un valore prognostico.
Questo studio, in altri termini, dimostra che un prolungato intervallo fra diagnosi e inizio di terapia motivato da problematiche cliniche (controllo di complicanze infettive e/o metaboliche) non ha alcun impatto sull’andamento della malattia, anche quando è maggiore di 45 giorni.
Nella pubblicazione, i ricercatori fanno notare che il gruppo con TDT compreso tra 15 e 30 giorni ha ottenuto risultati leggermente migliori rispetto agli altri gruppi. La differenza non è statisticamente significativa e, precisa Molica, potrebbe essere casuale. Tuttavia nella pubblicazione segnalano un altro recente studio che ha mostrato risultati simili in termini di tempo di sopravvivenza globale: i pazienti che cominciavano il trattamento (ipometitanti + venetoclax in questo caso) tra 8 e 15 giorni dalla diagnosi hanno avuto risultati migliori sia rispetto ai pazienti che cominciavano subito il trattamento (0-7 giorni), sia rispetto a quelli che ritardavano (>15 giorni).
Ė possibile quindi che esista una “finestra temporale” ottimale per l’inizio del trattamento che, da una parte, consenta di avere il tempo necessario per trattare adeguatamente le complicanze correlate alla AML e, dall’altra, di disporre dei dati biologici per una migliore personalizzazione della terapia. Una migliore definizione di questo importante aspetto di pratica clinica implica la necessità di disporre di maggiori dati di letteratura.
“Lo step successivo è quello di validare ulteriormente i risultati relativi all’impatto prognostico dell’intervallo fra diagnosi e tempo alla terapia in pazienti trattati con una combinazione di ipometilanti e venetoclax”, conclude Molica.
La pubblicazione originale è disponibile a questo link: http://dx.doi.org/10.4084/MJHID.2024.055