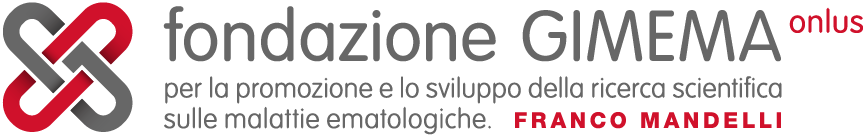“È presto per dire che la combinazione vemurafenib, un inibitore del gene BRAF mutato, e rituximab riesca a curare la leucemia a cellule capellute (HCL), ma sicuramente, rispetto alla somministrazione di vemurafenib da solo questa combinazione offre al paziente resistente a tutte linee di terapia convenzionali di ottenere delle remissioni di durata molto lunga”, commenta Brunangelo Falini, professore ordinario di Ematologia all’Università degli Studi di Perugia.
E continua: “Per ora possiamo sicuramente dire che è diventato lo standard di terapia per il paziente con HCL chemioresistente”.
Quella a cui fa riferimento Falini è una serie di studi iniziati con Enrico Tiacci nel 2011 con una importante scoperta: mediante sequenziamento del genoma si è scoperto che la mutazione del gene BRAF (BRAF-V600E) è responsabile dello sviluppo della leucemia a cellule capellute (HCL). L’HCL è una forma di leucemia cronica che determina una marcata riduzione di globuli bianchi, globuli rossi e piastrine. La mutazione del gene BRAF determina la trasformazione neoplastica dei linfociti B maturi, che assumono un peculiare aspetto morfologico: delle propaggini citoplasmatiche simili ai capelli si dipartono dalla superfice delle cellule, da cui il nome stesso della malattia. È una malattia rara, con un’incidenza stimata di 1 caso ogni 500.000 persone ed è molto più frequente negli uomini che nelle donne. Se non trattata la HCL può causare nei pazienti infezioni molto gravi.
GIMEMA Informazione ha intervistato Brunangelo Falini per sapere di più su quella che potrebbe essere una scoperta fondamentale per i pazienti affetti da HCL.
Com’è nata la linea di ricerca?
“Sulla base di quel primo studio del 2011 è emersa la possibilità di mettere a punto un test diagnostico molecolare basato proprio sul gene BRAF mutato e di utilizzare la mutazione come un bersaglio terapeutico. Infatti, proprio in quel periodo era già stato messo a punto un inibitore di BRAF chiamato vemurafenib. Questo veniva utilizzato nella terapia del melanoma metastatico che, nel 50% dei casi, porta la stessa mutazione della HCL. La sola differenza sta nel fatto che, nel melanoma metastatico la mutazione avviene in una melanocita – cellula dell’epidermide – mentre nella HCL in una cellula linfoide. Da qui abbiamo avviato uno studio, poi pubblicato sul The New England Journal of Medicine nel 2015, in cui abbiamo valutato l’efficacia di vemurafenib nei pazienti HCL resistenti ai trattamenti convenzionali.
Così facendo abbiamo dimostrato che vemurafenib da solo era in grado di indurre una risposta in quasi il 90% dei pazienti. Di questi, circa il 30% presentava una risposta completa con una durata mediana intorno ai 9 mesi a cui faceva seguito, però, una ripresa della malattia”.
Cosa avete fatto, dunque, per contrastare la ripresa della malattia?
“Abbiamo pensato di combinare l’inibitore con un altro agente biologico, il rituximab. Questo è un anticorpo monoclonale che si lega all’antigene CD20 delle cellule B provocandone la morte cellulare.
L’obiettivo era colpire le cellule leucemiche residue che erano resistenti al vemurafenib responsabili della ripresa della malattia. Dunque, abbiamo adottato una terapia di combinazione, vemurafenib e rituximab, e abbiamo pubblicato questi dati nel 2021 sempre sul New England Journal of Medicine.
In questo studio, abbiamo dimostrato che la combinazione dell’inibitore con il rituximab ha dei notevoli vantaggi. Per esempio, mentre somministrando solo l’inibitore si ottiene una remissione completa soltanto nel 30% dei pazienti, con la combinazione dei farmaci si ottiene una remissione completa in quasi il 90% dei pazienti. Inoltre, la combinazione dei due permette una remissione in un mese, mentre somministrando solamente il vemurafenib i pazienti ottenevano la remissione in più di due mesi. La cosa più importante però è che mentre i pazienti trattati solo con vemurafenib mostravano la presenza di cellule leucemiche residue, il 60% dei pazienti che andava in remissione completa con la combinazione di farmaci non aveva più cellule leucemiche residue. In parole povere, un incredibile vantaggio in termini di sopravvivenza da parte dei pazienti. Ancora oggi, a 48 mesi di follow-up, abbiamo una notevole percentuale di pazienti che è in remissione completa e rimane tale”.
Qual era lo standard di terapia, fino ad oggi, nel paziente con leucemia a cellule capellute resistente ai trattamenti convenzionali?
“Fino al momento della nostra scoperta venivano somministrati degli analoghi delle purine, in particolare la cladribina e la pentostatina, due farmaci citotossici che si utilizzano per la prima linea. La loro azione è semplice: una volta all’interno dell’organismo vengono convertiti nei linfociti in una sostanza chimica in grado di intervenire nella produzione di nuovo DNA o RNA, impedendo la divisione cellulare e rallentando la progressione della leucemia. In caso di recidiva il paziente ripeteva nuovamente questo trattamento e, se questo continuava a non funzionare, l’unica altra possibilità era combinare le chemioterapia con il rituximab”.
Recentemente avete pubblicato delle linee guida sul trattamento della HCL. Potrebbe dirci di più?
“Si parla di uno studio pubblicato nel 2022 su Blood in cui, insieme a De Carolis e Tiacci, abbiamo definito quelle che sono, a nostro parere, le linee guida per l’impiego degli inibitori di BRAF da soli o in combinazione con rituximab nella terapia dei pazienti con leucemia a cellule capellute.
Abbiamo identificato tre casi paradigmatici per evidenziare alcune situazioni in cui il vemurafenib poteva essere particolarmente utile, anche in prima linea, come quando un paziente si presenta con un’infezione grave. In questa situazione, il vemurafenib, che non è tossico per il midollo osseo, si rivela un agente efficace contro la leucemia senza abbassare le difese dell’organismo, a differenza degli analoghi delle purine che determinerebbero un calo di globuli bianchi e un potenziale aggravamento dell’infezione stessa”.
Qual è il futuro per questa linea di ricerca?
“Una possibile via la sta tracciando la Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro. Stiamo per iniziare uno studio clinico che metterà a confronto la miglior terapia standard possibile: ovvero la somministrazione di un analogo delle purine più rituximab a confronto con vemurafenib più rituximab. Se quest’ultima combinazione dovesse rivelarsi ugualmente efficace ma meno tossica, potrebbe addirittura essere proposta come terapia di prima linea senza chemioterapia”.